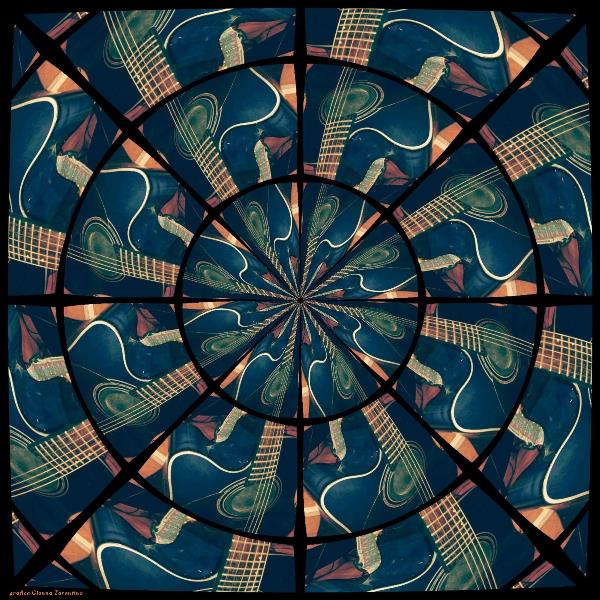Conferenza di
Luigi Turinese, tenuta presso il
Centro culturale L’Areopago della parrocchia di
S.Melania in Roma il
30 maggio 2005Il testo che mettiamo a disposizione on-line è la trascrizione della conferenza tenuta da Luigi Turinese, presso il Centro culturale L’Areopago della parrocchia di S.Melania in Roma il 30 maggio 2005. Il testo non è stato rivisto dall’autore. Conserva pertanto anche i tratti e lo stile di una conversazione trascritta dalla viva voce.
L’Areopago--------------------------------------------------------------------------------
Diamo il benvenuto a
Lugi Turinese, psicoterapeuta analista junghiano che ha curato l'anno scorso un libro pubblicato da Bollati Boringhieri, dal titolo “
Caro Hillman”. Sono 25 lettere indirizzate ad
Hillman da varie persone del mondo della cultura, tra le quali
Carotenuto, scomparso da poco,
Franco Battiato ed altri. Io ho avuto la gioia di conoscere Luigi un po'’ di tempo fa, in occasione della decisione di suo figlio di ricevere il battesimo. Poi è andato ad abitare in un altro quartiere e ci siamo visti in qualche occasione e abbiamo parlato di buddismo. Aveva curato sulla rivista dell'’
Unione Buddista Italiana una serie di recensioni, in particolare di libri sui rapporti tra il cristianesimo ed il buddismo, testi cristiani contemporanei che parlavano del buddismo e testi buddisti che parlavano del cristianesimo. Ho pensato di invitarlo perché ci introduca su questo tema: “
il buddismo in Occidente”.Siamo in un contesto di dialogo religioso sempre più necessario in cui deve essere chiaro qual è l’identità di ognuno. Io sono convinto che il dialogo tra le religioni non possa avvenire tra persone che fingono di non essere quello che sono. Ognuno deve anzi essere profondamente consapevole ed anche fiero di ciò che è, ma, insieme, coltivare un grande desiderio di conoscenza, di comprensione dell'altro diverso da sé. La famosa “intercultura” della quale tanto si parla nelle nostre scuole, non significa il silenzio o l'’indifferenza sulle particolarità delle culture, ma, anzi, l'approfondimento di ognuna di esse e, chiaramente, anche del cristianesimo.
In particolare per il buddismo credo si ponga in maniera ancora più peculiare il problema di quale sia la sua identità, di quale sia la sua storia. Sapete che il cristianesimo crollerebbe se venissero a mancare alcuni pilastri storici, poiché esso è profondamente legato alla storia del personaggio
Gesù. Abbiamo fatto degli incontri quest’anno sul
Gesù storico, che abbiamo già messo a disposizione on-line sul nostro sito
http://www.santamelania.it/. Ascolteremo da
Luigi Turinese quali siano i pilastri sui quali si fonda il buddismo, se sia costitutivo il suo radicarsi nella reale vicenda del
Buddha storico, quale sia il suo statuto di religione, quale la concezione buddista della divinità.
Luigi TurineseGrazie, sono contentissimo di essere stato invitato da
don Andrea perché è un grosso personaggio e credo che nella sua magnanimità, come tutte le persone grandi, proietti la sua grandezza all’esterno e mi abbia sopravvalutato.
Intanto il titolo che ha dato
don Andrea è più bello di quanto lui abbia detto ora. Il titolo esatto è “
Fascino e rischi del buddismo in Occidente”. Ogni volta che si parla di un tema è importante esaminare bene proprio il titolo, perciò io partirei da qui. Che vi sia un fascino del tema è indubbio: c'è tanta gente che quasi se ne fa un vanto di spostarsi verso Oriente. La cosa è cominciata probabilmente già dall’
800 in Europa, “
ex Oriente lux”, e poi
Schopenhauer e poi tutti gli altri. Nel nostro quarto di secolo, soprattutto alla
fine del secolo scorso, certamente la versione che è arrivata delle pratiche orientali è stata filtrata dal consumismo occidentale. Questo lo dico immediatamente. Il buddismo è infatti una disciplina molto complessa che arriva qui edulcorata e semplificata. Tutto quello che va sotto il nome di
new age ingloba anche delle pratiche orientali mescolate, delle quali il buddismo diventa la versione un po' più “
in”. Sapete che esiste una setta buddista giapponese, che misteriosamente si è espansa in tutto l'’Occidente, la
Soka Gakkai, che è una setta nata nel
1200, diventata famosa in occidente per l'’aggressività delle sue proposizioni, abbracciata facilmente da persone dello spettacolo e dello sport, il più famoso dei quali è
Roberto Baggio. Vedremo che la versione del buddismo che così ci arriva è molto, troppo semplificata. Oltretutto diciamo pure che il buddismo ha, per sua stessa natura, una grande duttilità. Cambia abbastanza i suoi connotati ben più di quanto abbia fatto, per esempio, il cristianesimo, a seconda delle zone in cui si è trapiantato.
Il buddismo nasce in
India tra il
VI ed il V secolo a.C. e oggi in
India praticamente non c'’è più.
Il buddismo nasce per opera di un personaggio che indubbiamente sfuma nella leggenda anche se probabilmente è un personaggio storico, però non vi sono evangelisti come per il cristianesimo. In quel lasso di tempo nel quale lavoravano alacremente i filosofi ad
Atene, un principe che si chiamava
Siddharta Gautama nacque e visse negli agi per una trentina di anni. Ci sono leggende sulla nascita che naturalmente era miracolosa, come in molti fondatori di religioni, e anche sull'’aneddoto che vuole che alla sua nascita l'’astrologo di corte predicesse un futuro da condottiero, oppure da condottiero di anime, da fondatore di religione. Il padre, che era un nobile, non voleva che si avverasse questa seconda ipotesi e quindi lo tenne nella bambagia, gli fece conoscere solo gli aspetti felici della vita. Un giorno però questo principe esce dal palazzo, si fa un giro per il regno e incontra, nell'ordine, un malato, un vecchio ed infine un funerale, tre cose che non aveva mai visto. Rimane molto turbato e sulla via del ritorno incontra un asceta. Questi quattro incontri lo turbano e lo trasformano, lo mettono di colpo in contatto con il dolore e con la morte. Va in casa, nel palazzo, dà un'occhiata alla moglie ed al figlio che dormono, prende un cavallo e scappa.
Siddharta aveva una moglie, faceva una vita da nobile, ora esce dal palazzo e va a rifugiarsi per anni presso alcuni asceti, ma questa via non lo soddisfa. Ritiene che quella condizione di mortificazione di sé non porti a molto. Comincia a meditare, fa voto di non muoversi dalla stessa posizione fino a che non avrà capito. Quando capisce si “risveglia” - perciò si chiama
Buddha che significa “
il risvegliato”.
Buddha è quindi un epiteto, un'’attribuzione successiva. E' un aggettivo. E questo vuol dire che chiunque può essere risvegliato: la natura di Buddha è potenzialmente di chiunque. Passeranno altri
45 anni di predicazione. Fonderà una comunità che si chiama
Sangha ed una dottrina che si chiama
Dharma. Vi do pure ora i termini tecnici - ve la voglio fare difficile - in modo che ricordiate che tutte le versioni che arrivano facilitate non sono buone.
Alla morte del Buddha c’è una sistematizzazione del pensiero e la stesura di quello che si chiama
tripitaka (o
tipitaka in pali). Il canone buddista è formato da una quantità enorme di libri.
Tripitaka in sanscrito significa “
tre canestri” perché erano originariamente rotoli nei canestri. Il
Suttapitaka (il canestro, “
pitaka”, dei discorsi), il
Vinayapitaka (il canestro della disciplina monastica), l'’
Abhidammapitaka (il canestro della dottrina). In realtà quest'’ultimo termine non è sanscrito, ma è pali, una lingua parlata. Diciamo che il pali sta al sanscrito come l'italiano volgare sta al latino. In sanscrito si dice d
harma, in pali
damma. In sanscrito si dice
sutra, in pali
sutta, in sanscrito si dice
nirvana, in pali
nibbana. Insomma il pali è “burino”!
Altre parole chiave sono
Hinayana e
Mahayana:
yana vuol dire veicolo,
hina piccolo,
maha grande.
La prima fase del buddismo è ristretta a pochi - il piccolo veicolo - e comprende una via soprattutto per monaci. Ideale del buddismo
Hinayana è “il santo” - diremmo noi - che però denota un essere avulso dal contesto sociale.
A partire dal
II secolo d.C. si sviluppa un buddismo molto più popolare, anche se ricco di speculazioni filosofiche di altissima qualità, che propone un veicolo più grande, il
Mahayana.
Maha significa grande - pensate a
Gandhi chiamato
Mahatma che vuol dire
grande anima o anche alla parola
maharaja che vuol dire
grande re. Il
Mahayana è un grande veicolo che è intanto più aperto, meno puramente monastico, e propone un ideale terminale di uomo che non è il semplice santo che si illumina di per sé e diventa Buddha e se ne va, ma si chiama
Bodhisatva che è una particolare qualità di essere umano che pur avendo compreso tutto decide di non entrare nel
Nirvana, ma di tornare in un’incarnazione successiva per aiutare tutti gli altri esseri umani.
Don Andrea potrebbe essere un
bodhisatva in questa accezione!
Cosa capisce
Siddharta tanto da meritare la qualifica di risvegliato?
Ve lo racconto così come lo racconta lui. Quattro enunciati secchi, chiamati
quattro nobili verità.Tutto è dolore: il buddismo è tosto, ve lo dico in modo che possiate riconoscere i falsi buddhismi. Non c'è altro che dolore, tutta la vita non è altro che sofferenza, malattia e morte. Anche quando sono felice e contento mi prende dopo un po’ l'’insoddisfazione e il timore di perdere ciò che ho. Diventa dunque dolore anche l’apparente brandello di felicità.
Vi è una causa di questo dolore. La sete, il desiderio di avere ancora dell'’altro, dovuto ad una ignoranza metafisica. Non vedo le cose come stanno, ma voglio solo per me, c’è il senso di separatezza dell’io dagli altri.
Vi è una cessazione del dolore. Quindi il dolore è onnipresente, ha come causa il desiderio egoistico. Può cessare, ma come? C’è un sentiero che conduce alla cessazione del dolore che è il sentiero del Buddha.
La via che ci porta fuori dal dolore è il retto ottuplice sentiero. Gli indiani sono dal punto di vista filosofico estremamente analitici. Anche il cosiddetto
Kamasutra, che tutti pensano sia un manuale erotico, in realtà è un noiosissimo elenco non tanto di posizioni quanto di qualità. Il sanscrito è complicatissimo, ha 48 suoni diversi, ho provato anche a studiarlo, ma è difficilissimo. Una lingua complicata vuol dire anche un pensiero complesso.
Vediamo il
retto ottuplice sentiero:saggezza1- Retta visione
2- Retto pensiero
etica3- Retta parola
4- Retta azione
5- Retta vita
disciplina mentale6- Retto sforzo
7- Retta attenzione
8- Retta concentrazione
Nel cristianesimo direi che la parte centrale storicamente, ma qui deve correggermi
don Andrea, è soprattutto
l’etica. Naturalmente non ci nascondiamo il fatto che esiste una pratica meditativa cristiana molto forte, ma direi che nell’evoluzione storica più popolare del cristianesimo si porta ad esempio soprattutto il blocco centrale, quello etico.
La meditazione buddista è invece molto importante, quindi la terza parte è al centro, in una dimensione meditativa che significa una grande attenzione che si persegue attraverso delle tecniche. Si riesce, secondo l'insegnamento buddista, ad avere, attraverso la meditazione, quello stato di calma mentale che permette le visioni rette di come stanno le cose. E cosa scopre il meditante che ha lavorato bene e che contempla anche, nel suo lavoro meditativo, un'’etica piuttosto rigorosa? Ho elencato alcuni concetti chiave del buddismo in modo che la cosiddetta dottrina ci appaia come l'esito di un percorso di comprensione. La prima è una verità abbastanza sconvolgente per noi occidentali:
Anatta (l’inesistenza di un io separato). Per i buddisti l’io non c'’è. Questo non vuol dire che io non esisto, ma la percezione di questo come un “io” separato da tutti gli altri è una falsa percezione, dovuta all’ignoranza. Allora quello che io aggrego a me e penso come
Luigi Turinese è un aggregato di sensazioni, sentimenti e ricordi che nel tempo si incrosta in una dimensione egoica che abbiamo l’abitudine di chiamare
Luigi Turinese o
Andrea Lonardo. Non esiste un Io separato. Questo comporterà dei grossi problemi nella reincarnazione, perché la prima cosa che si chiede ad un buddista è: ma allora chi è che si reincarna?
Anicca (non esiste nulla di permanente). Questo concetto è più vicino a noi se non altro perché conosciamo la filosofia greca:
Eraclito,
panta rei. Tutto scorre, non c'è nulla di permanente. Anche ciò che sembra più antico e strutturato è soggetto a passare.
Samsara (La vita ordinaria fatta di continue nascite e morti). Il buddismo sta all'’induismo come il cristianesimo sta all'ebraismo. Cioè il buddismo si configura come un ramo eterodosso dell’induismo. Allora alcuni concetti li prende da lì, come quello di
karma. Il karma è fondamentalmente una legge di azione-reazione. Faccio una cosa e produco un effetto. Questo è vero, lo possiamo vedere nelle vite di chiunque. Solo che per gli indiani, che hanno un tempo ciclico, questo effetto non si ferma con la morte fisica, ma continua anche dopo. Quindi produrre un effetto dopo l'altro può portare ad incarnazioni successive che sono effetto a loro volta della vita precedente. Su un piano banale, se mi comporto bene mi reincarno meglio, però non è tanto un concetto di retribuzione, di pena. Non c'è nessuno che dice: “Vai all'inferno”, ma ci vado da solo, nel senso che se ottundo la mia comprensione al punto che muoio totalmente ignorante in senso metafisico, la successiva incarnazione mi vedrà in una forma vitale più ottusa. Addirittura una forma animale. Nel buddismo c’è una eredità di questo concetto di
karma e più o meno esiste anche lì il concetto di reincarnazione, comunque una ruota di nascite e di morti. A proposito di reincarnazione ho letto un articolo di
Pietro Cantoni, di orientamento cristiano. Per noi occidentali, o almeno per gli occidentali più superficiali, la reincarnazione appare abitualmente come una cosa positiva: si torna a vivere. Per un indiano non va bene questa cosa: il massimo della sciagura che si possa augurare a qualcuno è: “Ti reincarnerai e tornerai”. Non vogliono tornare! Perché, se tutto è dolore, ricomincio daccapo. L'obiettivo finale di liberazione per un buddista è non incarnarsi mai più, non tornare. Noi che stiamo benino, consumisti come siamo, pensiamo alla reincarnazione e ci piace molto l'’idea delle religioni orientali, così si torna! L'obiettivo finale è invece l'’estinzione, il
Nirvana.Nirvana. Per certi versi il
Nirvana è l'antitesi del
Samsara. Non vi racconto le evoluzioni filosofiche successive che vedono uno come lo sfondo dell'altro, ma per semplificare vi basti sapere che il
Samsara va fuggito come la morte. E la nascita peggio ancora perché è l’esito di un atto di ignoranza che precedentemente non mi ha portato a vedere come stanno le cose e quindi non mi ha svegliato. Il risveglio coincide con la fine del
Samsara e l'’entrata nel
Nirvana (espirazione, estinzione). Il
Nirvana è molto desiderato.
 Pratitysaasamuptada
Pratitysaasamuptada (dodici punti uno concatenato all'’altro, l'’ultimo si chiama
avidya che significa
ignoranza). E’ un nesso causale implacabile che fa vedere come dalla nascita fino all'’ignoranza e quindi poi ad una rinascita si entra in un vortice infernale di rinascite continue. Noi possiamo dire, psicologicamente, che ogni nostra vita è un' infernale ruota di nascite e morte, illusioni e disillusioni, piccole nascite e piccole morti. Per loro vale nel tempo ciclico dell'’eternità, è una visione spaventosa. Quando capiamo quali sono tutti questi nessi, non c'’è più ignoranza, ma saggezza e si arriva alla visione della realtà come vuoto.
Sunya (Vuoto), caratteristica fondante della realtà. Dobbiamo fare attenzione al significato esatto dei termini, noi siamo occidentali e quando diciamo vuoto pensiamo alla noia e agli sbadigli. Vuoto è invece un concetto che allude alla non sostanzialità delle singole cose. Nessuna cosa è sostanzialmente esistente, se non in relazione a tutte le altre. Quindi il fondamento ultimo della realtà è il vuoto.
Abbiamo visto in questa prima parte il principe
Siddharta che si illumina -
VI-V secolo a.C. Muore ad
ottant’anni, probabilmente per l'’ingestione di carne avariata. Non muore sulla croce, ma di morte più o meno naturale. Morendo va nel
Nirvana. In un testo buddista si legge: “
Dopo la mia morte siate per voi stessi la vostra isola, il vostro rifugio” (Digha-nikaya, II). Lascia ai monaci piangenti questa ingiunzione. Buddha è un fondatore di religione, una religione molto filosofica e psicologica, ma non è Dio, non si proclama Dio. Non solo, ma il buddismo in qualsiasi manuale è definito una religione atea. Questo è discutibile: il Buddha riconosceva più come metafore che come sostanziali realtà, proprio perché la realtà gli sembra insostanziale, alcune divinità dell’induismo, così tanto per tenerle buone. Ma del problema di Dio non ha mai voluto parlare perché le questioni metafisiche, a lui che era il medico, sembravano una perdita di tempo. Nel canone buddista ci sono varie storie del genere, la principale delle quali è questa. All'’ennesima domanda: “
Cosa c’è dopo la morte? Ma c'è un Dio?”, lui replicava in modo secco raccontando di quell'’uomo che viene colpito da una freccia. Quell'’uomo quando viene colpito da una freccia e qualcuno va a soccorrerlo, non chiede solo di essere soccorso? Pensate che cominci a chiedere: “Ma com'’era quello che ha scoccato la freccia? Era alto o basso? Raccontatemi com'’era”.
No, non chiede questo, vuole solo essere liberato dal dolore. Quindi fondamentalmente taglia con le questioni metafisiche portando su una sfera pratica la sua predicazione.
Nel
vangelo di Giovanni invece, una delle cose che dice Gesù è questa: “
Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv. 13,34). Vedete la differenza enorme con la frase lasciata da Buddha prima di morire: “Dopo la mia morte siate per voi stessi la vostra isola, il vostro rifugio”. Nel cristianesimo c'è una prospettiva intersoggettiva, interrelazionale, che nel buddismo originale non c’è.
Vi dico questo perché credo che sia essenziale il problema sollevato da
don Andrea sull'’identità. Lo stesso
Dalai Lama dice:
“Fate attenzione alle facili conversioni perché sarebbe come mettere su un corpo di capra la testa dello yak”. Viene fuori un mostro. Questo dell'’identità è un grande problema. Il cristianesimo, per come l'’ho capito, è molto relazionale. Intanto c'’è il concetto di
Trinità, che è un concetto di tipo relazionale, perché ci sono le
tre Persone che sono interfacciate. Spero di non dire bestialità teologiche. Questo penso che porti proprio il tema fondante di tipo relazionale.
Nella
Genesi c'’è poi la somiglianza tra Dio e uomo che è ontologica e questo pure è un elemento relazionale e poi la comunione da un certo punto di vista è un elemento fortemente relazionale. Questi sono alcuni elementi del cristianesimo, non sono chiaramente tutti:
Trinità
Somiglianza Dio-uomo
Centralità della comunioneNe ho scelti tre per il buddismo:
Nirvana
Non-dualità
VacuitàSono tre elementi irrelati. Siamo in un’ottica completamente diversa, per questo i trapianti non sono facili. Il senso del vuoto, della vacuità, che è peraltro concetto filosoficamente molto interessante e che il cristianesimo ha sfiorato soprattutto con quella che si chiama
mistica apofatica (
Meister Eckhart ma forse anche
Dionigi l'’Areopagita), ma che per il cristianesimo sono concetti un po'’ secondari.
Naturalmente non è che i buddisti non si aiutino gli uni con gli altri, però sono centrati da un'’altra parte.
Voglio comparare anche un'’altra triade. Nel buddismo abbiamo visto che il peggior peccato è l'’ignoranza in fondo di come stanno le cose, la replica è la saggezza di come stanno le cose. Quando vedo che tutto è vuoto, che non esistono realtà separate, che reincarnarsi è la suprema abiezione, tutto questo è elemento di saggezza, si raggiunge con pratiche meditative. La reincarnazione è una iattura, non c'’è da augurarsi.
Nel cristianesimo viceversa c’è la nozione di peccato che naturalmente mi ripropone un'’idea di un'’anima individuale che è completamente diversa dal concetto di
Anatta che abbiamo visto prima. Il peccato si riscatta con il perdono e alla fine viene promessa la resurrezione. Se promettete la resurrezione ad un buddista quello fa gli scongiuri, perché è da un'’altra parte che stiamo andando. Non ho alcuna pretesa di dire quale delle due è meglio, ma voglio solo farvi vedere che sono due concezioni pressoché incompatibili proprio sul piano logico.
C’è un aforisma che recita:
Nel buddismo tutto si spiega senza Dio,nel cristianesimo nulla si spiega senza Dio.Tutto si spiega senza Dio non vuol dire che il buddismo sia ateo, questa è una semplificazione. E'’ importante tutta la successione dei dati che abbiamo sin qui esaminato. Il buddismo è quasi agnostico, non è importante se esiste o no un Dio.
Nel cristianesimo nulla si spiega senza Dio tanto che io ritengo pericolosi i viraggi puramente etici del cristianesimo, le frange di puro riscatto morale. Qualunque laicismo può proporre un'’etica più che dignitosa, ma la chiave religiosa implica un altro tipo di esperienza.
Io sono stato presentato come psicoterapeuta junghiano e voglio leggervi una frase proprio di
C.G.Jung:”Io vorrei mettere in guardia contro la così spesso tentata imitazione e assimilazione delle pratiche orientali. Di regola, non ne viene che un istupidimento particolarmente artificioso del nostro intelletto occidentale”.Questo istupidimento può essere l'esito di un tipo di coscienza che si è declinata nei secoli in occidente che ha bisogno probabilmente di un nutrimento diverso. Non vorrei che tutto questo sembrasse una
captatio benevolentiae nei confronti del parroco, però raccoglievo la sfida da lui lanciata con il titolo di questo incontro:
fascino, perché di fascino ce n'’è molto,
e rischi. Il rischio è quello della capra con la testa dello yak. L'’istupidimento artificioso del nostro intelletto si vede nei visi di tanti praticanti di religioni orientali occidentali che, a mio parere, eludono la prima nobile verità, che tutto è dolore, cioè la tragicità dell'’esistenza, che poi è un'’idea anche greca, che viene meno a favore di pratiche pacificanti. Si va a meditare per stare meglio, non per capire meglio.
Io suggerirei qui una citazione da
san Paolo:Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono (I Tessalonicesi V,21)Le pratiche buddiste serie, quelle più asciutte che non raccontano tante cose ma insegnano delle tecniche di osservazione di sé, possono essere un buon ponte verso la comprensione di ciò che effettivamente siamo e sono in questo modo esportabili anche in ambiti cristiani o addirittura non confessionali. Sono pratiche fondamentalmente psicologiche. Non solo, ma se vogliamo hanno condotto diversi cristiani a riscoprire la propria tradizione, perché poi si sono imbattuti in pratiche come quella dell'’esicasmo, tipica del cristianesimo d'’Oriente che coniuga la preghiera con la respirazione e quindi è come se fosse un'’espressione orientaleggiante ma nata in ambito cristiano. Ci sono altri elementi poco noti del cristianesimo che hanno punti di contatto.
Bisogna poi considerare che esistono in realtà delle versioni diversissime del buddismo a seconda del Paese nel quale il buddismo si è trapiantato. Per esempio il
buddismo zen che è tipico del
Giappone, implica poche cerimonie e molta pratica meditativa fondata sull'’attenzione. Il meditante si siede e osserva il suo respiro. Detto così sembra una sciocchezza, in realtà non solo è calmante, ma può portare ad osservare se stessi e tutta una serie di cose e soprattutto è una pratica che pare faccia bene anche a chi ha altre convinzioni teologiche. Ci sono stati sacerdoti che hanno lavorato in
Giappone e, senza arrivare a sincretismi sciocchi, hanno scoperto ancora di più la propria religione, come
H. M. Enomiya Lassalle, gesuita tedesco, che ha lavorato molto in
Giappone e ha anche scritto dei libri molto belli sull'’incontro tra alcune pratiche zen e il cristianesimo.
Zen vuol dire
meditazione, in realtà in sanscrito meditazione si dice
dhyana, in cinese
dhyana diventa
ch'an e dalla Cina
ch'an diventa
zen in Giappone. Nel
Tibet invece dove c'’era una tradizione sciamanica fortemente magica, il buddismo si è trapiantato con una quantità di deviazioni quasi magiche. Se vedete una immagine buddista tibetana vi rendete conto del chiasso di divinità. Ho appena detto che il buddismo è agnostico, ma in
Tibet trova tutto questo retroterra magico e cultuale e viene fuori un
buddismo tibetano che tra l'’altro è molto diffuso perché c'’è stata la diaspora con il
Dalai Lama nel
1959, cacciato con tutti i tibetani. Il
Dalai Lama è un'’icona mediatica ormai e quindi si pensa che il buddismo sia quello, ma in realtà quello del
Dalai Lama nasce come buddismo di minoranza. Se fosse rimasto in Tibet non lo avrebbe conosciuto nessuno.
Abbiamo poi il
buddismo di Nichiren, nel quale ci si siede due volte al giorno recitando il
Sutra del loto in giapponese. A me sembra una pratica istupidente perché tra l'altro è in una lingua che non ci appartiene. Tra l'altro la setta di
Nichiren nasce nel
1200 con un'’ottica nazionalista e militarista. Da noi ci sono milioni di praticanti che non sanno queste cose.
Direi per chiudere che il buddismo ci può riportare ad una conoscenza di noi, ma pencolarsi verso l'altro è conoscitivo solo se ho un'identità abbastanza stabile. Non è così difficile da capire, vale anche per le relazioni affettive. Non conosco davvero l'altro se non ho una buona identità personale, questo vale anche per le culture.

Concludo con dei cenni bibliografici per chi volesse approfondire:
Pasqualotto, G.
Il buddismo. I sentieri di una religione millenaria – Bruno Mondadori
Franci, G.R.:
Il buddismo – Il Mulino
Gnoli R. (a cura di):
La rivelazione del Buddha I e II - Mondadori
Dalai Lama:
La strada che porta al vero. Come praticare la saggezza nella vita quotidiana – Mondadori
D.Gira:
La scelta che non esclude – Mondadori
H.C.Puech: Storia del buddismo - Mondadori
In foto: "Sacred ribben IV" e " Croce-mandala"
Conferenza pubblicata online qui