Le leggende sui Maya sono tante, e la loro ricchezza trae un certo alimento dalle scarse notizie storiche che possediamo: come dire che l'immaginazione umana, per sua natura mitopoietica, si esalta di fronte all'indefinito.
Indefinito che, nel caso dei Maya, non ha origine da un'antichità perduta nei secoli, ma purtroppo nella meticolosità dello sterminio attuato nei loro confronti dai bianchi europei.
Lo sterminio non fu soltanto diretto verso le persone ma, cosa non meno atroce, verso i documenti di questa civiltà: se sono sopravvissute vestigia architettoniche, non è stato difficile eliminare i documenti scritti. Soltanto tre codici conservati in tre biblioteche di altrettante città europee, sopravvissero alla distruzione: uno di questi, il cosiddetto Codice di Parigi (gli altri due sono il Codice di Dresda e quello di Madrid) è stato studiato a fondo da Paul Arnold, già presidente dell'Unione Buddhista Europea e mitologo di fama.
Arnold sostiene che nel 2500 a.C. i Maya giunsero nel continente americano provenienti dall'Asia. A sostegno delle sue ipotesi invoca non solo le somiglianze etnico-antropologiche, ma anche e soprattutto le affinità linguistiche tra i glifi maya e gli ideogrammi cinesi.
Nel testo appare essenziale la fede nel ritorno dei trapassati, ciò che giustifica il titolo del libro: una sorta di rapporto tra i vivi e i morti senza le implicazioni della cultura indiana.
La rinascita, al contrario, viene qui auspicata in quanto unico modo di assicurare continuità alla specie umana.
Luigi Turinese
 In foto: "Apocalisse prossima ventura"
In foto: "Apocalisse prossima ventura"Recensione apparsa nella rubrica "Libri" di "PARAMITA, Quaderni di Buddhismo", Anno XII, n.47, Luglio-Settembre 1993


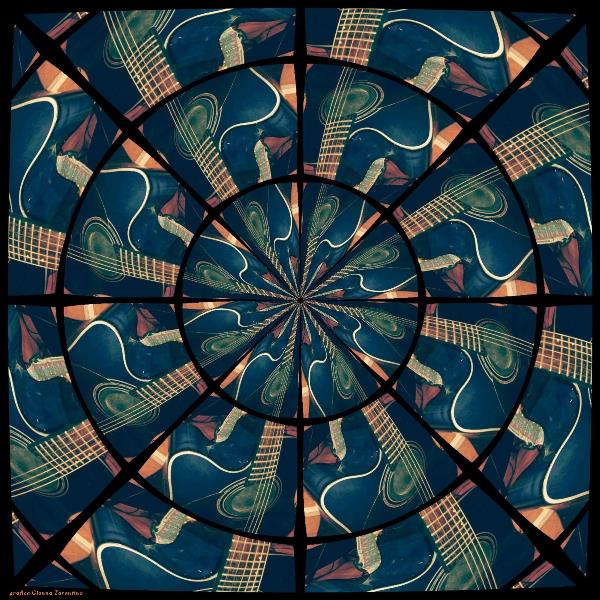
Nessun commento:
Posta un commento