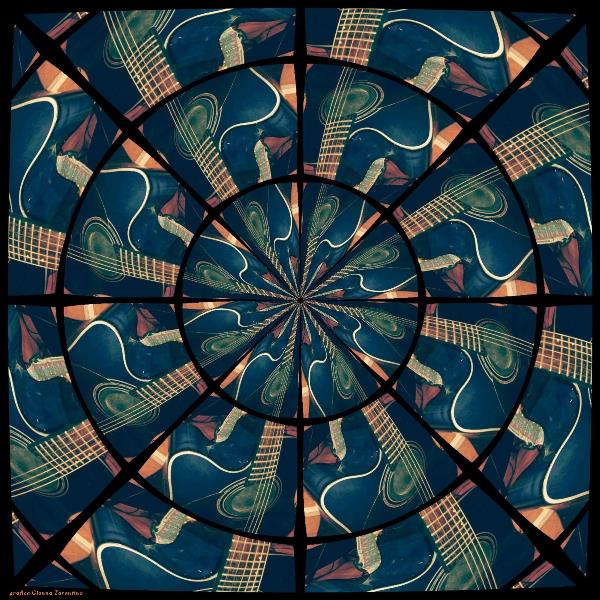Nel suo insieme, la vasta opera di
James Hillman appare “
sistematicamente a-sistematica”, impegnata a decostruire, decisamente postmoderna. Cionondimeno, vi si possono rintracciare alcune costanti:
1. Un’enfasi sulla
nozione di anima,
tertium tra spirito e corpo.
2. Un recupero dell’
immagine come dato primario, irriducibile.
3. Una
re-visione della clinica, in cui la psicopatologia è situata su uno sfondo archetipico.
4. Una
re-visione della teoria della personalità nella direzione di una molteplicità ontologica in luogo della centralità di un io monolitico
.(Vai al post: Che cos'è la Psicologia Archetipica?)Su tali quattro pilastri,
Hillman ha edificato la sua
psicologia archetipica, che si configura come un ramo eterodosso della
psicologia analitica di
Jung, della quale enfatizza la nozione di
archetipo.
Gli archetipi sono le
forme primarie e universali del
funzionamento psichico: ogni esperienza personale appare come un fenomeno secondario appartenente a uno sfondo primario che ne è appunto l’archetipo.
Il compito della psicologia archetipica consiste nel rivelare il modello archetipico delle varie forme di comportamento. Alla luce di questo concetto, si comprende come sia illegittimo, oltre che ingenuo, prendere alla lettera i comportamenti umani. Si rende pertanto necessario un lavoro di
deletteralizzazione che
Hillman definisce poeticamente come
visione in trasparenza e che – sola – consente una lettura psicologica della realtà. In tal modo, gli
eventi accidentali assumono una pienezza di senso e
divengono esperienze.
Già da queste prime note si può comprendere come venga di fatto proposta l’esistenza di una
doppia realtà: una letterale, accidentale, insensata; l’altra nascosta, originaria, dotata di senso. A questo punto, non stupisce che
Hillman ponga alla base della psicologia archetipica il principio dell’
epistrophè, mutuato dalla filosofia neoplatonica.
Fondatore del neoplatonismo fu
Ammonio Sacca, che tuttavia non scrisse nulla, simile in questo a
Socrate. Ammonio fu simile a Socrate anche per aver avuto un allievo fecondo,
Plotino (
205-270), autore di
sei libri composti ciascuno di
nove trattati e per questo chiamati
Enneadi. Secondo
Plotino,
ciascuna realtà affonda in un principio che la tiene unita. Ciò è vero tanto sul piano fenomenico quanto su quello metafisico. All’origine di ogni cosa, difatti, vi è
l’Uno, principio primo in-finito e dunque in-definibile. Si può dire solo che cosa Esso
non sia ma è impossibile darne predicati: si può accostarvisi con una teologia negativa o
apofatica. Dall’Uno si dipartono involontariamente
Emanazioni che danno origine alla molteplicità. Questo fenomeno, chiamato
proodòs (
via verso il basso), dà luogo a
tre ipostasi: il mondo delle idee
>immagini,
l’anima e infine
la materia.
L’anima è la facoltà attraverso la quale l’uomo, servendosi delle arti, dell’amore, della filosofia, può attingere l’unità perduta. Portato dalla nostalgia dell’Uno, in sé inattingibile, l’uomo può pervenire alla
prima ipostasi, vero e proprio
mundus imaginalis o
archetypalis. Tale processo, speculare rispetto al
proodòs, si chiama
epistrophè, perché è un
percorso di ritorno.
L’
epistrophè è ulteriormente elaborata negli
Elementi di teologia di
Proclo (
412-485), in particolare nella proposizione
29.
Proclo chiama in causa esplicitamente gli dèi della tradizione pagana, attribuendo loro un valore causale rispetto alla realtà. Esiste per tutti i fenomeni una forma archetipica a cui essi possono essere ricondotti.
Epistrophè è un metodo che ha lo scopo di
ritrovare le immagini originarie. Esso procede per somiglianza, in un certo senso omeopaticamente. Inaugurato dai filosofi neoplatonici,
l’esercizio dell’epistrophè viene applicato in contesti insospettabili, anche inconsapevolmente: si pensi allo sforzo dello psicologo di ricondurre sintomi privi di senso al loro sfondo archetipico; operazione, anche questa, di
conversione verso l’origine.
Epistrophè, appunto.
Prossimo per certi versi agli scenari neoplatonici, sia pure con peculiarità sue proprie, è il misticismo sviluppatosi in area islamica a partire dal
XII secolo. Due sono le figure di spicco di questo movimento. Il persiano
Sohrawardî (
1154-1191) è il primo a dare un fondamento ontologico a quel vero e proprio intermondo, situato tra il mondo sensibile e quello spirituale, che prende il nome di
‘âlam al-mithâl. Questo
mundus imaginalis è il luogo delle visioni teofaniche, delle immaginazioni dei mistici e dei poeti. Si tratta di un mondo dotato di una sua concretezza, di una sua estensione e popolato di figure-archetipi. Il filosofo mistico
Ibn ‘Arabî (
1165-1240), arabo di Spagna, stabilisce una metafisica del
mundus imaginalis e dell’
immaginazione creatrice – come la definisce
Henry Corbin – che ne è l’organo naturale, intermediario tra il pensiero e l’essere.
 In foto: "Arabeschi"
In foto: "Arabeschi" Il procedimento che consente l’accesso a tale zona intermedia è omologo all’
epistrophè e si chiama
ta’wil. Questa parola significa
“ricondurre una cosa alla sua origine, al suo archetipo”.
“Nel ta’wil si dovrebbero riportare forme sensibili a forme immaginative, e di qui risalire a significati ancora più alti”, scrive
Henry Corbin, il massimo studioso occidentale del misticismo sufi di orientamento sciita. Il
ta’wil, tra l’altro, è alla base dell’ermeneutica esoterica del Corano. Difatti si contrappone ed è complementare al
tanzîl, che designa la lettera della Rivelazione, ponendosi come scienza che rivela, esegesi esoterica che riconduce l’essoterico al suo archetipo (
asl). In tal modo si realizza una comprensione del senso profondo del
tanzîl, attraverso il superamento della schiavitù del letteralismo. Letteralismo, si badi bene, non solo del Libro ma anche di ogni dato di natura essoterica (
zâhir), cui corrisponde un dato di natura esoterica, interiore, nascosta (
bâtin). Il
ta’wil attiva la coscienza immaginativa, facoltà conoscitiva intermedia tra l’intellezione pura e la percezione sensibile, tra il pensiero e l’essere. Esso riconduce dal simbolo al simbolizzato. L’organo che presiede tali operazioni gnostiche
è il cuore, non a caso indagato a fondo da
James Hillman, che scrive, seguendo
Corbin:
“L’azione caratteristica del cuore non è il sentimento, ma la visione” (
Hillman:
L’anima del mondo e il pensiero del cuore).
Questo
locus metaphoricus attraversa la tradizione occidentale sin dalla michelangiolesca
immagine del cuor. La
psicologia archetipica si fonda sull’immagine e sull’immaginazione, concepita non già come una semplice facoltà umana ma come un’attività dell’anima, ben distinta dall’attività del fantasticare. Si comprende dai suoi precursori e dai suoi riferimenti culturali come la psicologia archetipica abbia anche un’implicazione assiologica, ridisegnando il sistema di valori a partire dal ridimensionamento del mito monoteistico dell’eroe – un altro modo di definire la psicologia dell’io. Si approda ad una prospettiva, che non esito a definire
chenotica, mirante a svuotare l’io, l’ontologia, la sostanzialità; un po’ come avviene in certe tradizioni orientali o in certa mistica apofatica cristiana – si pensi a
Meister Eckhart.
La molteplicità dell’anima, d’altra parte, richiama una fantasia teologica politeistica, suggererendo la presenza di implicazioni soteriologiche nella psicologia archetipica.
Sebbene lo stesso
Hillman abbia ripetutamente mirato a conservare una prospettiva immanente al lavoro dell’archetipo, è tuttavia legittimo scorgere nella sua opera una tangenzialità, quanto meno, con il discorso spirituale: quelli che, sia pure sommessamente, non esito a definire
semi di trascendenza.
Luigi TurineseRiferimenti BibliograficiCorbin, H.(
1964,1974,1986):
Storia della filosofia islamica, Adelphi, Milano
1973 e
1989.
Corbin, H. (
1958:
L’immaginazione creatrice, Laterza, Roma-Bari
2005.
Corbin, H.(
1971):
L’uomo di luce nel sufismo iraniano, Mediterranee, Roma
1988.
Hillman, J. (
1979):
Il sogno e il mondo infero, Il Saggiatore, Milano
1988.
Hillman, J. (
1973, 1975, 1976, 1979): Saggi sul Puer, Raffaello Cortina, Milano
1988.
Hillman, J.:
Archetypal Psychology, Spring Publications, Putnam, Connecticut
1983, 2004.
Hillman, J. (
1974, 1981, 1982):
L’anima del mondo e il pensiero del cuore, Garzanti, Milano
1993.
Hillman, J. (
1999):
La forza del carattere, Adelphi, Milano
2000.
Miller, D./Hillman, J. (
1981):
Il nuovo politeismo, Edizioni di Comunità, Milano
1983.
Intervento presentato a Siracusa il 15 dicembre 2007 durante il convegno "Epistrophè, discesa (agli Inferi) e ritorno" organizzato
dal Centro Culturale Epicarmo in collaborazione con
l'Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica
Pubblicato su "La Rivisata dei Dioscuri - Trimestrale policulturale e politeista", n.2 Aprile-Giugno 2011, pagg.19-21
 In foto: "J.H." - di Gianna Tarantino
In foto: "J.H." - di Gianna Tarantino